
Emanuele Aldrovandi è drammaturgo, sceneggiatore, regista, scrittore. Soprattutto però, è uno che con le parole ci sa fare.
Il suo mondo interiore lo esprime con i testi che, in tutte le loro forme, continuano a trasmettere qualcosa che ancora non si è visto. Sulle pagine crea trasparenze, ma anche enigmi irrisolti, modi di vivere mai conosciuti, abbracci non dati, frasi non dette. Tra i suoi scritti c’è insomma quello che ancora non c’è: un’idea, quella avuta da Aldrovandi, che funziona alla grande e che gli ha permesso di ottenere un premio dopo l’altro, tra cui il Nastro d’Argento.
A lui, però, tutto questo non interessa, perché il suo unico obiettivo è parlare ai cuori della gente e farlo con quelle parole che si trovano dentro di lui e che riesce spesso a tirar fuori. D’altronde, i suoi testi sono stati messi in scena nei più grandi teatri italiani e sono stati tradotti e pubblicati in diverse lingue del mondo. Adesso ha pubblicato un romanzo – Il nostro grande niente (Einaudi Editore) – che parla di un’assenza che si fa presenza, e di un silenzio che urla. In tutto questo contraddirsi, l’autore ha rilasciato un’intervista alle nostre pagine, in occasione della sua partecipazione al Festival letterario Lungomare di Libri di Bari, e si è raccontato per quello che è ma soprattutto per quello che è sempre stato.
La scrittura, il luogo in cui ti rifugi da sempre. Ricordi quando hai iniziato a riconoscerti in lei? All’inizio sapevi già quale sarebbe stato il tuo percorso?
Che sarei riuscito a farlo diventare il mio lavoro? No, non lo sapevo. Lo desideravo sin da quando ho fatto i primi corsi di teatro negli anni dell’Università. Io ho sempre scritto racconti e dialoghi, ma lì ho scoperto che mi riusciva bene cimentarmi nella scrittura. Mi sono così iscritto all’Accademia e ho investito su questo mondo, cercando di trasformare la passione in lavoro. Adesso sono ormai 15 anni che scrivo teatro: per me la scrittura va intesa come un rifugio solitario, ma anche un momento di incontro, che accade quando invento una storia che viene rappresentata sul palco dagli attori.
Drammaturgo, sceneggiatore e regista: ti definisce così la tua biografia. Chi sei però nella vita di tutti i giorni?
Una persona ironica, che cerca comunque che questa cosa coincida nelle cose in cui vivo. La caratteristica principale è che cerco di guardare le cose con ironia: a volte è bello e piace ma altre volte fa arrabbiare. La mia personalità incide moltissimo nel mio modo di scrivere, non ho mai fatto ricerche di mercato e ho sempre chiesto quello che mi andava di scrivere. Questo crea una repulsione verso tutta l’arte didattica. La letteratura contiene infatti molti romanzi che ci insegnano come si può diventare un buon cittadino. Anche io voglio esserlo nella vita, ma nei miei interessi non c’è affatto scrivere per portare avanti dei principi. Io scrivo per esplorare dei dubbi e anche per indagare su qualcosa che non so.
La tua carriera ti ha portato a ricevere diversi premi, tra cui anche il Nastro d’Argento. Quanto influisce, ogni volta, il riconoscimento del pubblico nei successivi lavori?
La cosa divertente è che, lavorando in tre ambiti diversi, il riconoscimento si azzera ogni volta che si cambia ambito. Fa piacere e aiuta un po’ a farsi ascoltare di più quando si propongono dei progetti. Più che i premi, mi interessa che le cose che faccio abbia un riscontro da parte del pubblico. Preferisco uno spettacolo che faccia 100 date e che non abbia alcun premio, e lo stesso vale anche nella letteratura.
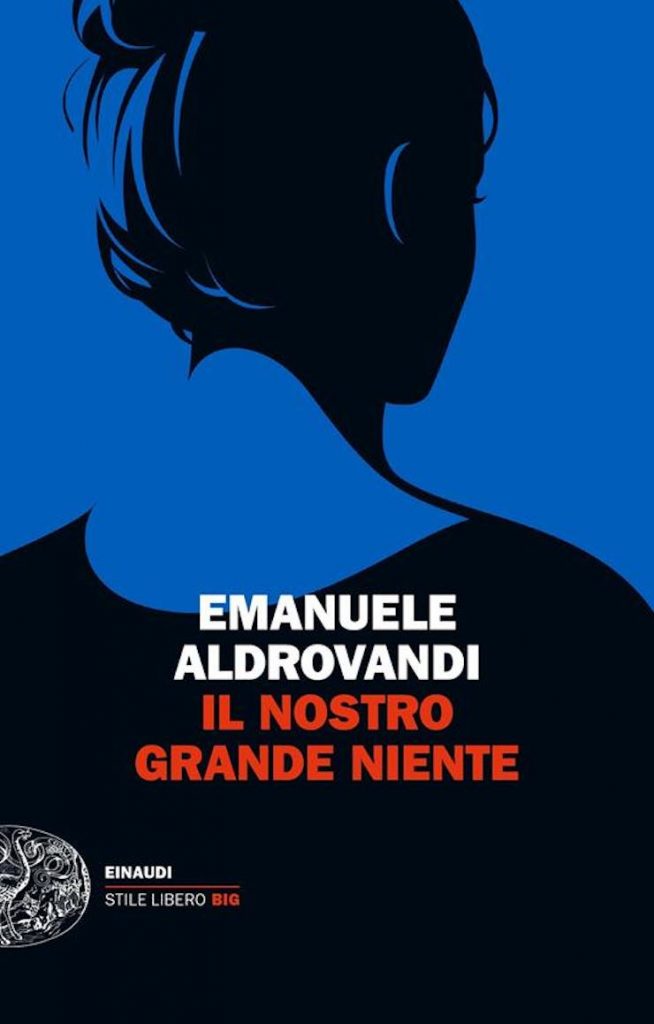
Il nostro grande niente di Emanuele Aldrovandi – kosmomagazine.it
Sei in libreria con il tuo primo romanzo, edito da Einaudi, “Il nostro grande niente”. Dove nasce l’idea?
Tutto è nato in un momento di grande felicità che ho vissuto, durante il quale le cose stavano andando molto bene. Mi sono quindi chiesto cosa sarebbe accaduto se fossi morto, ed è quello che accade al protagonista. Muore e vede tutto andare in pezzi dopo la sua morte: tutto nasce dal rapporto tra la fine e il senso di quello che facciamo. Si crea così un rapporto tra lo trovare un senso di ciò che facciamo e la consapevolezza del baratro in cui spariremo quando non ci saremo più. L’ho scritto perché è il tempo di storia di un narratore assente per una serie di motivi tecnici: scrivendo mi sono infatti reso conto che sarebbe stata più adatta la forma del romanzo che quella dell’opera teatrale.
Si parla di amori, dell’importanza delle relazioni e anche dell’eternità dei sentimenti. Sono valori in cui hai sempre creduto? Chi te li ha insegnati?
Non credo in nessuno di questi valori. Da relativista metto sempre in discussione tutti i miei principi. È proprio quello che fa il protagonista del mio libro. L’assenza viene messa in crisi e, alla fine, si ritrova da solo ad affrontare quello che succede. Non ci credo, ma amo senza credere nell’amore. Oscillo tra l’idea di cercare qualcosa di assoluto e che sia immanente rispetto alla vita e il non riuscire a credere fino in fondo.
Qual è il feedback che stai ricevendo e quali erano inizialmente le tue aspettative?
Non avevo aspettative, l’ho scritto perché mi andava di scriverlo e mi interessava scrivere questa storia. Quello che mi ha stupito è che ho avuto feedback opposti tra chi mi dice che è un libro nichilista che dà malinconia, e chi dice che mette invece molta allegria. Mi colpisce che ci sono due estremi opposti e che restituisce la complessità del romanzo. Io diffido della letteratura che offre soluzioni, non so perché siamo arrivati ad aspettarci una letteratura consolatoria e didattica. La storia della letteratura non è mai consolatoria, ma continua a porre domande a cui spesso non vengono date risposte.
Futuri progetti?
A settembre girerò un film, ho un nuovo spettacolo che debutta nel 2025 e una tournée teatrale. Ci sono inoltre idee per dei nuovi libri.



